Don Marco Ceccarelli, Commento IV Domenica Quaresima “C”
IV Domenica Quaresima “C” – 31 Marzo 2019
I Lettura: Gs 5,9-12
II Lettura: 2Cor 5,17-21
Vangelo: Lc 15,1-3.11-32
- Testi di riferimento: Gn 3,10-4,1; Dt 8,3; 1Sam 15,13-23; Sal 73,23.27; 127,2; 139,18; Sap 3,1; Is
65,5; Ger 31,25; Os 2,9-10; Am 8,11; Mal 3,14-15; Mt 20,10-12; Lc 1,53; 4,25-28; 6,21-25; 9,24;
13,3.5; 17,27; 18,9.21; 19,9-10; Gv 6,27; 10,28-30; 17,10; At 22,21-22; Rm 3,20-28; 8,39; 10,19;
1Gv 1,6-8
1. La parabola presente nel brano di Vangelo odierno offre tanti spunti e principalmente viene usata
per parlare della misericordia del Padre, del perdono, del ritorno da una situazione di peccato alla
casa di Dio. Certamente anche qui prevale la tematica della conversione. Tuttavia non solo il figlio
scialacquone (= prodigo) è chiamato a convertirsi, ma anche e soprattutto il figlio maggiore. Infatti,
possiamo chiederci dove sia il punto focale della parabola. Chi la intitola “il figlio prodigo” sottolinea l’importanza della sua conversione; chi “il padre misericordioso” privilegia l’aspetto di accoglienza e di compassione. Però, ripeto, qual è il punto fondamentale della parabola? (una parabola
ha sempre un “punto”, anche se può certamente contenere tanti diversi aspetti didattici; e questa ne
contiene veramente tanti). È essenziale tenere presente che Gesù dice la parabola per “loro” (v. 3),
cioè per quei farisei e scribi che mormoravano a motivo del fatto che egli «riceve i peccatori e mangia con loro» (v. 2). Non a caso la parabola non si conclude al v. 24 (avrebbe avuto già un senso
pieno), ma prosegue ulteriormente per descrivere l’atteggiamento del figlio maggiore. Ciò significa
che quest’ultima parte è tutt’altro che secondaria. La parabola infatti è detta per coloro che sono
rappresentati dal figlio maggiore e che sono quelli che hanno più difficoltà a convertirsi. Infatti anche il figlio maggiore deve compiere una conversione, ma il problema è che non se ne rende conto.
Perché?
2. La conversione per il figlio maggiore.
- Nella scrittura l’empio, il peccatore, è colui che ritiene di poter gestire la propria vita in autonomia
da Dio. Molto spesso questo stile di vita appare redditizio, conveniente. Spesso chi non vuole rispondere ad un’autorità superiore sembra così libero da poter fare quello che vuole, ed essere felice.
Sembra spesso che le cose vadano meglio a lui che agli altri. Così anche il giusto non di rado è tentato di seguire la stessa via (a questo proposito è utile riflettere sul Salmo 73). Dunque il figlio
maggiore – e con lui tutti i farisei e gli scribi di questo mondo – pensa che il fratello se la stia spassando, se la stia godendo; e lo si capisce dal fatto che si arrabbia nel momento in cui lo scialacquone
viene riaccolto, in festa, a casa. Perché si arrabbia? Perché lui non ha abbandonato la casa paterna,
lui si è “sacrificato” a lavorare mentre il fratello si divertiva. Però in fondo pensava: dopo lui sarà
punito e io sarò premiato. È l’atteggiamento di chi vede il peccato come una cosa buona che purtroppo non si può fare. Però, pensa lui, se io mi sforzo dal non peccare dopo sarò premiato (paradiso) e gli altri saranno puniti (inferno). Invece risulta che il fratello scialacquone torna a casa e gli
fanno pure festa. Allora si capisce perché si arrabbia. E avrebbe anche ragione, se il suo modo di
pensare, se il suo modo di considerare il peccato, fosse giusto.
- Ma la realtà è diversa; la realtà è quella affermata dal padre. Il peccato non è per nulla una felicità.
Al contrario è una morte e una perdizione (vv. 24.32); mentre la vera felicità sta nella comunione
con Dio. Questo è quanto il giusto del Sal 73 ha capito dopo essere stato tentato di seguire le vie
degli empi. Chi è lontano da Dio perisce (Sal 73,27), mentre la felicità è stare sempre con Dio (Sal
73,23). Per questo il padre della parabola dice: «Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo»
(v. 31). Questo è il punto chiave. Niente può separare il giusto dall’amore di Dio, tranne il cadere
nella tentazione di porsi al livello dell’empio. La nostra vita va verso la comunione piena e definitiva con Dio, e tutto sta nel non separarsene mai, resistendo a tutte le tentazioni che mirano a farcela
perdere. Se siamo tristi come il figlio maggiore, pur essendo nella casa del Padre, non è certo per
colpa di Lui. Egli ci lascia completamente liberi e ci dà tutto ciò che vogliamo. La tristezza è causata da altro. Dunque entrambi i figli non hanno capito che la felicità non sta nel separarsi da Dio, ma
al contrario nella comunione con Lui. Però il secondogenito ritorna.
3. La conversione per il figlio scialacquone.
- Le due parabole precedenti, quella della pecora e della dracma perduta, sono legate alla nostra e
utili per la sua interpretazione. In esse appare sempre il binomio perdere-ritrovare (Lc 15,4-10). Il
pastore perde la pecora e poi la ritrova. La donna perde la moneta e poi la ritrova. Anche il figlio
scialacquone si era perso (vv. 24.32); però ora non si dice che qualcuno lo ritrova. Non è il padre
che è andato a cercarlo. In un certo senso si è ritrovato da solo. Ma cosa lo ha mosso a ritornare, a
convertirsi, a sentire il desiderio della vita precedente? Una cosa molto semplice: la fame. Questa
fame che ha sentito è stata la sua salvezza. Arriva un momento in cui tanti che si sono allontanati
dal Padre – che hanno voluto “ciò che gli spetta” (v. 12), pensando di essere padroni di qualcosa,
della loro vita, del loro tempo, dei loro soldi, ecc. – sentono fame.
- Sentire fame significa sentire un vuoto, sentirsi – come dice chiaramente il figlio – sulla soglia di
una “morte sciagurata” (v. 17). Sentono cioè che quel loro modo di usare i beni non ha dato loro la
sazietà, la felicità. C’è una fame interiore, un desiderio profondo di vita, che non si soddisfa con cibi materiali. C’è uno stomaco spirituale, un vuoto dentro di noi, che vuole essere riempito. Tanti
sentono questa “fame” e cercano di appagarla con divertimenti, dandosi alla pazza gioia, usando tutto quello che hanno a disposizione per saziarla. Ma nonostante tutto arriva un punto in cui quella
fame è più forte che mai. E tanti, pur avvertendo questa indigenza, non sanno più dove rivolgersi.
Arrivano a percepire che tutto quello che hanno fatto non li ha resi felici, ma non sanno che altro fare. Se hanno avuto una qualche esperienza della casa del Padre forse anche loro si renderanno conto, come il figlio prodigo, che si stava meglio lì, nella Chiesa. Ma se non ci sono mai stati come lo
scopriranno? Per questo Cristo sta insieme ai peccatori, perché è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto (Lc 19,10); è venuto a portare il vero cibo che sazia e che è lui stesso. Per questo la
Chiesa non può non continuare la stessa missione di Cristo di portare gli uomini alla sazietà della
comunione con Dio. «Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati» (Lc 6,21).
4. Ora possiamo capire come il titolo dovrebbe essere probabilmente “la parabola dei due fratelli”.
La storia gioca, come spessissimo accade nel Vangelo di Lc, sul contrasto fra due personaggi e fra
due atteggiamenti, per indicare quale tipo di comportamento sia quello giusto, quello che conduce
alla vita eterna, alla felicità. Tale felicità è indicata nel racconto con la metafora della festa. Chi entra nella festa è il fratello minore, quello che apparentemente non ne aveva più diritto. Egli si sarebbe considerato fortunato, avrebbe ritenuto come vincere alla lotteria, soltanto se il padre gli avesse
concesso un posto fra i servi, fra gli ultimi della casa. Invece chi era già nella casa, chi era proprietario delle stesse cose del padre, chi non mancava di nulla, è rimasto fuori dalla festa. Non è lo stare
materialmente all’interno delle mura ecclesiastiche che produce automaticamente l’essere felici. La
conversione, l’atteggiamento di gratitudine, di riconoscenza, e quindi di gioia, per avere dei doni
inestimabili, è spesso − ci dice la parabola − meno presente in chi sta dentro la casa del Padre.
Fonte:http://www.donmarcoceccarelli.it/
I Lettura: Gs 5,9-12
II Lettura: 2Cor 5,17-21
Vangelo: Lc 15,1-3.11-32
- Testi di riferimento: Gn 3,10-4,1; Dt 8,3; 1Sam 15,13-23; Sal 73,23.27; 127,2; 139,18; Sap 3,1; Is
65,5; Ger 31,25; Os 2,9-10; Am 8,11; Mal 3,14-15; Mt 20,10-12; Lc 1,53; 4,25-28; 6,21-25; 9,24;
13,3.5; 17,27; 18,9.21; 19,9-10; Gv 6,27; 10,28-30; 17,10; At 22,21-22; Rm 3,20-28; 8,39; 10,19;
1Gv 1,6-8
1. La parabola presente nel brano di Vangelo odierno offre tanti spunti e principalmente viene usata
per parlare della misericordia del Padre, del perdono, del ritorno da una situazione di peccato alla
casa di Dio. Certamente anche qui prevale la tematica della conversione. Tuttavia non solo il figlio
scialacquone (= prodigo) è chiamato a convertirsi, ma anche e soprattutto il figlio maggiore. Infatti,
possiamo chiederci dove sia il punto focale della parabola. Chi la intitola “il figlio prodigo” sottolinea l’importanza della sua conversione; chi “il padre misericordioso” privilegia l’aspetto di accoglienza e di compassione. Però, ripeto, qual è il punto fondamentale della parabola? (una parabola
ha sempre un “punto”, anche se può certamente contenere tanti diversi aspetti didattici; e questa ne
contiene veramente tanti). È essenziale tenere presente che Gesù dice la parabola per “loro” (v. 3),
cioè per quei farisei e scribi che mormoravano a motivo del fatto che egli «riceve i peccatori e mangia con loro» (v. 2). Non a caso la parabola non si conclude al v. 24 (avrebbe avuto già un senso
pieno), ma prosegue ulteriormente per descrivere l’atteggiamento del figlio maggiore. Ciò significa
che quest’ultima parte è tutt’altro che secondaria. La parabola infatti è detta per coloro che sono
rappresentati dal figlio maggiore e che sono quelli che hanno più difficoltà a convertirsi. Infatti anche il figlio maggiore deve compiere una conversione, ma il problema è che non se ne rende conto.
Perché?
2. La conversione per il figlio maggiore.
- Nella scrittura l’empio, il peccatore, è colui che ritiene di poter gestire la propria vita in autonomia
da Dio. Molto spesso questo stile di vita appare redditizio, conveniente. Spesso chi non vuole rispondere ad un’autorità superiore sembra così libero da poter fare quello che vuole, ed essere felice.
Sembra spesso che le cose vadano meglio a lui che agli altri. Così anche il giusto non di rado è tentato di seguire la stessa via (a questo proposito è utile riflettere sul Salmo 73). Dunque il figlio
maggiore – e con lui tutti i farisei e gli scribi di questo mondo – pensa che il fratello se la stia spassando, se la stia godendo; e lo si capisce dal fatto che si arrabbia nel momento in cui lo scialacquone
viene riaccolto, in festa, a casa. Perché si arrabbia? Perché lui non ha abbandonato la casa paterna,
lui si è “sacrificato” a lavorare mentre il fratello si divertiva. Però in fondo pensava: dopo lui sarà
punito e io sarò premiato. È l’atteggiamento di chi vede il peccato come una cosa buona che purtroppo non si può fare. Però, pensa lui, se io mi sforzo dal non peccare dopo sarò premiato (paradiso) e gli altri saranno puniti (inferno). Invece risulta che il fratello scialacquone torna a casa e gli
fanno pure festa. Allora si capisce perché si arrabbia. E avrebbe anche ragione, se il suo modo di
pensare, se il suo modo di considerare il peccato, fosse giusto.
- Ma la realtà è diversa; la realtà è quella affermata dal padre. Il peccato non è per nulla una felicità.
Al contrario è una morte e una perdizione (vv. 24.32); mentre la vera felicità sta nella comunione
con Dio. Questo è quanto il giusto del Sal 73 ha capito dopo essere stato tentato di seguire le vie
degli empi. Chi è lontano da Dio perisce (Sal 73,27), mentre la felicità è stare sempre con Dio (Sal
73,23). Per questo il padre della parabola dice: «Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo»
(v. 31). Questo è il punto chiave. Niente può separare il giusto dall’amore di Dio, tranne il cadere
nella tentazione di porsi al livello dell’empio. La nostra vita va verso la comunione piena e definitiva con Dio, e tutto sta nel non separarsene mai, resistendo a tutte le tentazioni che mirano a farcela
perdere. Se siamo tristi come il figlio maggiore, pur essendo nella casa del Padre, non è certo per
colpa di Lui. Egli ci lascia completamente liberi e ci dà tutto ciò che vogliamo. La tristezza è causata da altro. Dunque entrambi i figli non hanno capito che la felicità non sta nel separarsi da Dio, ma
al contrario nella comunione con Lui. Però il secondogenito ritorna.
3. La conversione per il figlio scialacquone.
- Le due parabole precedenti, quella della pecora e della dracma perduta, sono legate alla nostra e
utili per la sua interpretazione. In esse appare sempre il binomio perdere-ritrovare (Lc 15,4-10). Il
pastore perde la pecora e poi la ritrova. La donna perde la moneta e poi la ritrova. Anche il figlio
scialacquone si era perso (vv. 24.32); però ora non si dice che qualcuno lo ritrova. Non è il padre
che è andato a cercarlo. In un certo senso si è ritrovato da solo. Ma cosa lo ha mosso a ritornare, a
convertirsi, a sentire il desiderio della vita precedente? Una cosa molto semplice: la fame. Questa
fame che ha sentito è stata la sua salvezza. Arriva un momento in cui tanti che si sono allontanati
dal Padre – che hanno voluto “ciò che gli spetta” (v. 12), pensando di essere padroni di qualcosa,
della loro vita, del loro tempo, dei loro soldi, ecc. – sentono fame.
- Sentire fame significa sentire un vuoto, sentirsi – come dice chiaramente il figlio – sulla soglia di
una “morte sciagurata” (v. 17). Sentono cioè che quel loro modo di usare i beni non ha dato loro la
sazietà, la felicità. C’è una fame interiore, un desiderio profondo di vita, che non si soddisfa con cibi materiali. C’è uno stomaco spirituale, un vuoto dentro di noi, che vuole essere riempito. Tanti
sentono questa “fame” e cercano di appagarla con divertimenti, dandosi alla pazza gioia, usando tutto quello che hanno a disposizione per saziarla. Ma nonostante tutto arriva un punto in cui quella
fame è più forte che mai. E tanti, pur avvertendo questa indigenza, non sanno più dove rivolgersi.
Arrivano a percepire che tutto quello che hanno fatto non li ha resi felici, ma non sanno che altro fare. Se hanno avuto una qualche esperienza della casa del Padre forse anche loro si renderanno conto, come il figlio prodigo, che si stava meglio lì, nella Chiesa. Ma se non ci sono mai stati come lo
scopriranno? Per questo Cristo sta insieme ai peccatori, perché è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto (Lc 19,10); è venuto a portare il vero cibo che sazia e che è lui stesso. Per questo la
Chiesa non può non continuare la stessa missione di Cristo di portare gli uomini alla sazietà della
comunione con Dio. «Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati» (Lc 6,21).
4. Ora possiamo capire come il titolo dovrebbe essere probabilmente “la parabola dei due fratelli”.
La storia gioca, come spessissimo accade nel Vangelo di Lc, sul contrasto fra due personaggi e fra
due atteggiamenti, per indicare quale tipo di comportamento sia quello giusto, quello che conduce
alla vita eterna, alla felicità. Tale felicità è indicata nel racconto con la metafora della festa. Chi entra nella festa è il fratello minore, quello che apparentemente non ne aveva più diritto. Egli si sarebbe considerato fortunato, avrebbe ritenuto come vincere alla lotteria, soltanto se il padre gli avesse
concesso un posto fra i servi, fra gli ultimi della casa. Invece chi era già nella casa, chi era proprietario delle stesse cose del padre, chi non mancava di nulla, è rimasto fuori dalla festa. Non è lo stare
materialmente all’interno delle mura ecclesiastiche che produce automaticamente l’essere felici. La
conversione, l’atteggiamento di gratitudine, di riconoscenza, e quindi di gioia, per avere dei doni
inestimabili, è spesso − ci dice la parabola − meno presente in chi sta dentro la casa del Padre.
Fonte:http://www.donmarcoceccarelli.it/



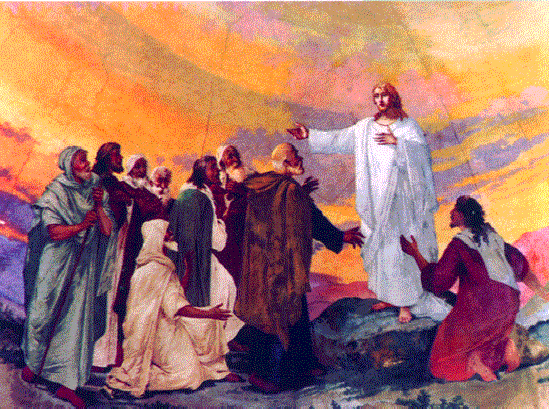
Commenti
Posta un commento